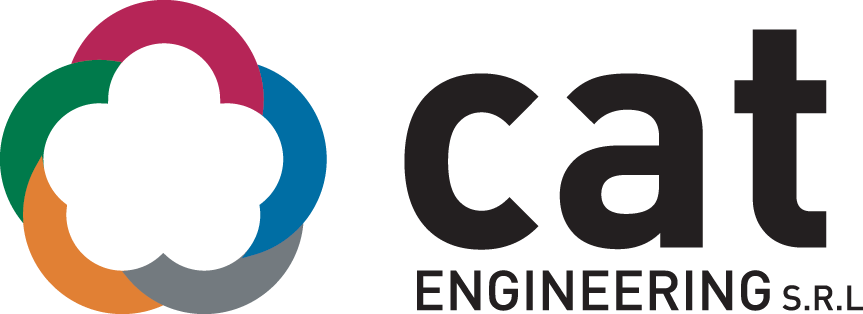CAT Engineering Srl si propone come partner per studio di fattibilità, progettazione esecutiva, progettazione dei sistemi di gestione per la direzione lavori e collaudo finale di infrastruttura di ricarica dei veicoli elettrici.
Possiamo progettare soluzioni impiantistiche delle stazioni di ricarica auto elettriche di ogni genere e per ogni tipologia di cliente:
amministrazioni pubbliche, parcheggi, privati, centri commerciali, alberghi, aziende, condomini, ecc.
__________________________________________________________________
DEFINIZIONI
«INFRASTRUTTURA DI RICARICA PER VEICOLI ALIMENTATI AD ENERGIA ELETTRICA»: un’infrastruttura elettrica, incluso il punto di ricarica, che per la sua realizzazione richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica o una modifica della connessione esistente;
«PUNTO DI RICARICA»: un’interfaccia in grado di caricare un veicolo elettrico alla volta o sostituire la batteria di un veicolo elettrico alla volta.
 __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
LEGISLAZIONE
DECRETO LEGISLATIVO 16 dicembre 2016, n. 257 Disciplina di attuazione della direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi.
Tra le novità introdotte dal d.lgs 257/2016 viene anche modificato l’art. 4 del Testo unico dell’edilizia (dpr 380/2001), con la previsione che:
dal 31 dicembre 2017, i Comuni devono adeguare il regolamento edilizio prevedendo che ai fini del conseguimento del titolo abilitativo edilizio sia obbligatoriamente prevista la predisposizione all’allaccio per la possibile installazione di infrastrutture elettriche per la ricarica dei veicoli
Tale obbligo riguarda:
- gli edifici di nuova costruzione ad uso diverso da quello residenziale con superficie utile superiore a 500 m2 e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello
- gli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unita’ abitative e per i relativi interventi di ristrutturazione edilizia di primo livello
Dovrà essere consentita la connessione di una vettura da ciascuno spazio a parcheggio coperto o scoperto e da ciascun box per auto, siano essi pertinenziali o meno, relativamente ai soli edifici residenziali di nuova costruzione con almeno 10 unità abitative, per un numero di spazi a parcheggio e box auto non inferiore al 20% di quelli totali.
STATO ATTUALE DELLA NORMATIVA
Le norme relative alle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici che contengono sia i requisiti di sicurezza che costruttivi, sia le prove a cui sottoporre i componenti del “sistema di ricarica per veicolo elettrico” per renderli affidabili e sicuri, sono elaborate contemporaneamente alla messa sul mercato dei veicoli elettrici, allo scopo di sincronizzare la normativa con le più recenti innovazioni tecnologiche, come verrà descritto più avanti. Purtroppo, la situazione attuale vede ora sul mercato “sistemi di ricarica” non conformi ai requisiti di sicurezza necessari per essere utilizzati da persone “non avvertite o formate”.
Nella Figura 2 sono stati riportati gli elementi fondamentali per consentire la carica di un veicolo con la terminologia che nel seguito verrà utilizzata. Si parla di sistema presa/spina sul lato stazione di carica e di connettori se ci si riferisce al lato veicolo.
 Elementi fondamentali per consentire la carica di un veicolo
Elementi fondamentali per consentire la carica di un veicolo
CEI EN 61851-1 SISTEMA DI RICARICA CONDUTTIVA DEI VEICOLI ELETTRICI
Attualmente la norma che riporta le prescrizioni necessarie per la ricarica dei veicoli elettrici è la Norma CEI EN 61851-1:2012-05 “Sistema di ricarica conduttiva dei veicoli elettrici – Parte 1: Prescrizioni generali”.
CEI EN 62196 SPINE, PRESE FISSE, CONNETTORI MOBILI E FISSI PER VEICOLI ELETTRICI
Attualmente sono normati (CEI EN 62196-2 “Spine, prese fisse, connettori mobili e fissi per veicoli – Carica conduttiva dei veicoli elettrici – Parte 2: Compatibilità dimensionale e requisiti di intercambiabilità di attacchi a spina e alveoli per corrente alternata”) 3 tipi principali di prese, spine e connettori specifici per la carica del veicolo elettrico in CA differenziati in funzione della corrente, della tensione nominale, del numero delle fasi e del numero dei contatti pilota, ovvero utilizzabili, con alcune restrizioni, per i modi di carica 3, 2 e 1 (Tabella 2)
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
l PNIRE è il piano nazionale di riferimento per tutti i soggetti che operano in materia di ricarica di veicoli elettrici.
Tra gli obiettivi principali del PNIRE c’è quello di istituire una Piattaforma Unica Nazionale (PUN) per fornire servizi informativi a tutti gli stakeholder interessati dallo sviluppo della mobilità elettrica. La Piattaforma prevede il controllo ed il monitoraggio delle infrastrutture di ricarica pubbliche finalizzato al controllo (per gli enti gestori) e alla fornitura di informazioni (per gli utenti finali), anche attraverso lo sviluppo degli Open Data.
__________________________________________________________________
Specifiche tecniche punti di ricarica
Dal 18 novembre 2017 sono operative le nuove specifiche tecniche relative ai punti di ricarica per i veicoli elettrici, come previsto dal dlgs 257/2016, all’art. 4 comma 5, secondo cui:
I punti di ricarica di potenza standard per i veicoli elettrici, escluse le unità senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all‘allegato I, punto 1.1, e ai requisiti specifici di sicurezza in vigore a livello nazionale. I punti di ricarica di potenza elevata per i veicoli elettrici, escluse le unita’ senza fili o a induzione, introdotti o rinnovati a decorrere dal 18 novembre 2017, si conformano almeno alle specifiche tecniche di cui all‘allegato I, punto 1.2.
Allegato 1, punto 1.1. I punti di ricarica di potenza standard a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di prese fisse o connettori per veicoli del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. Mantenendo la compatibilità del tipo 2, tali prese fisse possono essere munite di dispositivi quali otturatori meccanici.
Allegato 1, punto 1.2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente alternata (AC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del tipo 2, quali descritti nella norma EN62196-2. I punti di ricarica di potenza elevata a corrente continua (DC) per veicoli elettrici sono muniti, a fini di interoperabilità, almeno di connettori del sistema di ricarica combinato «Combo 2», quali descritti nella norma EN62196-3
Il d.lgs 257/2016 recepisce la Direttiva 2014/94/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, con l’obiettivo di raggiungere l’interoperabilità dei sistemi di ricarica su tutto il territorio dell’Unione Europea.
Di seguito vediamo le specifiche introdotte dalla normativa europea per le infrastrutture per la mobilità elettrica sia per automobili sia per veicoli leggeri, quali scooter e motocicli ed in particolare analizzeremo i seguenti aspetti:
- sistemi di carica
- tipi di connessione
- modi di carica
Sistemi di carica
Attualmente sono definiti 3 tipi di connessione per la carica e 4 modi di carica per un totale teorico di quasi 12 varianti sul tema senza contare i diversi tipi di connettori, prese e spine.
La corrente (e quindi la potenza) di carica è ovviamente inversamente proporzionale ai tempi di carica, ma da un punto di vista dell’impianto può rapidamente raggiungere valori abbastanza elevati di potenza da erogare.
Nella tabella seguente riportiamo i tempi tipici di carica per autovettura elettrica di media taglia.

-
Ricarica lenta. Impiega da 6 a 8 ore per la ricarica completa del veicolo. La potenza è inferiore ai 10 kW.
-
Ricarica quick. La ricarica completa varia da 2 a 3 ore con una potenza erogabile di 22 kW.
-
Ricarica rapida. Funziona sia con corrente alternata sia con corrente continua ed offre tempi più veloci rispetto a tutti gli altri tipi di ricarica.
Tipi di connessione
Secondo la normativa europea, i tipi di connessione attualmente normati per la carica dei veicoli elettrici sono 3 in funzione del lato o dei lati dotati di connessione non fissa:

1. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e una spina permanentemente fissati al veicolo stesso
2. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione removibile provvisto di connettore mobile e spina per il collegamento alla presa di alimentazione in c.a.
3. il veicolo elettrico è connesso al punto di carica utilizzando un cavo di alimentazione e un connettore mobile permanentemente fissati all’apparecchiatura di alimentazione
Modi di carica
Attualmente ci sono 4 modi di carica differenziati in funzione delle seguenti caratteristiche:
- regime (CA, CC)
- corrente massima
- tipo di connettore
- presa/spina
- eventuale comunicazione/controllo tra il veicolo e la stazione di carica
Modo 1
Il Modo 1 di carica si riferisce al collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione CA (Corrente Alternata) utilizzando prese e spine normate fino a 16 A, ovvero ordinarie prese e spine per uso domestico o industriale oppure prese e spine speciali ma comunque conformi ad una (qualsiasi) norma internazionale IEC.
Nei Paesi in cui è consentito, l’uso del modo 1 di carica potrebbe, per un certo periodo, rimanere la modalità di ricarica più diffusa per locali privati (compresi garage residenziali e parcheggi aziendali) grazie alla semplicità e al basso costo d’investimento.
Con una corretta realizzazione e aggiornamento dell’impianto elettrico, il Modo 1 consente la ricarica in sicurezza.
Il modo 1 di carica può essere paragonato ai sistemi elettrici di preriscaldo dei motori, che sono di uso comune nei paesi del nord Europa da molti anni senza aver manifestato alcun problema di sicurezza.

Modo 2
Anche il Modo di carica 2 per il collegamento del veicolo elettrico alla rete di alimentazione prevede prese e spine conformi ad uno standard IEC, International Electrotechnical Commission, (ordinarie o ad hoc) ma con corrente nominale fino a 32 A.
L’introduzione del Modo di carica 2 è stato inizialmente pensato per gli Stati Uniti e considerato una soluzione transitoria in attesa dello sviluppo di infrastrutture dedicate.
Recentemente, tuttavia, il Modo 2 sembra aver destato un rinnovato interesse anche in Europa, nella prospettiva di sostituire il Modo 1 per la carica presso punti non dedicati.
Oltre agli ovvi svantaggi di avere un dispositivo di controllo posizionato sul cavo, lo svantaggio principale del Modo 2 è che il box di controllo protegge il cavo a valle e il veicolo, ma non la spina stessa, che in realtà risulta essere uno dei componenti più soggetti ad usura.

Modo 3
Il Modo di carica 3 prevede il collegamento diretto del veicolo elettrico alla rete CA (Corrente Alternata) di alimentazione utilizzando apparecchiature di alimentazione dedicate. La norma internazionale richiede un contatto pilota di controllo tra il sistema di alimentazione e il veicolo elettrico con le seguenti funzioni:
- inserimento dei connettori
- continuità del conduttore di protezione
- funzione di controllo attiva.

Modo 4
Il modo di carica 4 è l’unico modo di carica che prevede il collegamento indiretto del veicolo elettrico alla rete CC (Corrente Continua) di alimentazione utilizzando un convertitore esterno, e un conduttore pilota di controllo che si estende alle attrezzature permanentemente collegate alla rete.
Con il modo di carica 4 il carica batterie non è più a bordo del veicolo ma nella stazione di carica.

Spine, prese fisse e connettori
Attualmente sono normati 3 tipi principali di prese, spine e connettori specifici per la carica del veicolo elettrico in CA differenziati in funzione della corrente, della tensione nominale, del numero delle fasi e del numero dei contatti pilota, ovvero utilizzabili, con alcune restrizioni, per i modi di carica 3, 2 e 1.
Esistono 5 tipologie di connettori.
-
Tipo 1. Per ricariche monofase in corrente alternata, per una potenza massima di ricarica di circa 7,3 kW, corrispondente a una corrente massima di 32A e una tensione di 230V. Si trova solo sul veicolo.
-
Tipo 2. Si usa per la ricarica in corrente alternata (AC) sia monofase sia trifase fino a 63 A, per una potenza massima di 43 kW. Si trova sia sul veicolo sia sulla colonnina.
-
Tipo 3. Può essere di due tipologie, 3A (diffuso in Italia) e 3C (diffuso in Francia). Il tipo 3A è alimentato in monofase 16 A per una potenza massima di 3 kW. Sono presenti solo sulla colonnina.
-
Tipo Chademo. È lo standard per la ricarica veloce in corrente continua e può fornire una potenza fino a 50 kW a una tensione di 500 V e corrente continua di 125 A con connettori dimensionati per supportare anche 100 kW di potenza.
-
Tipo Combo 2. È il connettore per la ricarica in corrente continua e può superare la potenza di 100 kW. Supporta anche la ricarica lenta, inglobando il connettore di tipo 2.
La scelta dei connettori dipende dal tipo di caricabatterie (presa) e dalla porta di ingresso del veicolo.
Sul lato caricabatterie, i caricabatterie rapidi utilizzano connettori CHAdeMO, CCS (Combined Charging Standard) o di tipo 2. Le unità veloci e lente utilizzano solitamente prese di tipo 2, tipo 1, Commando o a 3 pin.
Sul lato del veicolo, i modelli EV europei (Audi, BMW, Renault, Mercedes, Mercedes, VW e Volvo) tendono ad avere prese di tipo 2 e il corrispondente standard CCS rapido, mentre i produttori asiatici (Nissan e Mitsubishi) preferiscono una combinazione di prese di tipo 1 e CHAdeMO. Ciò non sempre si applica, tuttavia, con la Hyundai Ioniq Electric e il Toyota Prius Plug-In come eccezioni.
La maggior parte dei veicoli elettrici sono forniti con due cavi per la ricarica lenta e veloce; uno con una spina a tre poli e l’altro con un connettore di tipo 2 lato caricabatterie, ed entrambi dotati di un connettore compatibile per l’ingresso dell’auto. Questi cavi consentono ad un EV di collegarsi alla maggior parte dei punti di ricarica non collegati, mentre l’uso di unità collegate richiede l’uso del cavo con il tipo di connettore corretto per il veicolo.
Alcuni esempi includono la Nissan Leaf, che di solito viene fornita con un cavo a 3 pin per tipo 1 e un cavo di tipo 2 per tipo 1. La Renault Zoe ha una diversa configurazione di ricarica ed è fornita con un cavo da 3 pin a Tipo 2 e/o da Tipo 2 a Tipo 2. Per una ricarica rapida, entrambi i modelli utilizzano il connettore collegato alle unità di ricarica.
Connettori di ricarica (VVF)
INFRASTRUTTURA
Un punto di ricarica può essere di potenza standard o di potenza elevata.
Si definisce standard un punto di ricarica, che consente il trasferimento di elettricità a un veicolo elettrico di potenza pari o inferiore a 22 kW, esclusi i dispositivi di potenza pari o inferiore a 3,7 kW, che sono installati in abitazioni private o il cui scopo principale non e’ ricaricare veicoli elettrici, e che non sono accessibili al pubblico.
Il punto di ricarica di potenza standard e’ dettagliato nelle seguenti tipologie:
- lenta = pari o inferiore a 7,4 kW;
- accelerata = superiore a 7,4 kW e pari o inferiore a 22 kW.
Un punto di ricarica di potenza elevata consente, invece, il trasferimento di elettricita’ a un veicolo elettrico di potenza superiore a 22 kW. Il punto di ricarica di potenza elevata e’ dettagliato nelle seguenti tipologie:
- veloce: superiore a 22 kW e pari o inferiore a 50 kW;
- ultra-veloce: superiore a 50 kW.
Il punto di ricarica in qualsiasi forma esso sia può essere pubblico o privato. Anche in questo caso la normativa specifica le differenze.
Un punto di ricarica o di rifornimento accessibile al pubblico: un punto di ricarica o di rifornimento per la fornitura di combustibile alternativo che garantisce un accesso non discriminatorio a tutti gli utenti. L’accesso non discriminatorio puo’ comprendere condizioni diverse di autenticazione, uso e pagamento. A tal fine, si considera punto di ricarica aperto al pubblico:
- un punto di ricarica la cui area di stazionamento e’ accessibile al pubblico, anche mediante autorizzazione e pagamento di un diritto di accesso;
- un punto di ricarica collegato a un sistema di autovetture condivise e accessibile a terzi, anche a seguito del pagamento del servizio di ricarica.
Un punto di ricarica non accessibile al pubblico:
- installato in un edificio residenziale privato o in una pertinenza di un edificio residenziale privato, riservato esclusivamente ai residenti;
- destinato esclusivamente alla ricarica di veicoli in servizio all’interno di una stessa entita’, installato all’interno di una recinzione dipendente da tale entità;
- installato in un’officina di manutenzione o di riparazione, non accessibile al pubblico.
__________________________________________________________________
DOCUMENTI DA PREPARARE E PRESENTARE
ATTIVITÀ LIBERA
Il decreto (D.Lgs 257/2016) stabilisce che la realizzazione di punti di ricarica in immobili e aree private anche aperte ad uso pubblico resta attività libera non soggetta ad autorizzazione nè a segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA) se sono rispettati i seguenti requisiti e condizioni:
- il punto di ricarica non richiede una nuova connessione alla rete di distribuzione elettrica né una modifica della connessione esistente;
- il punto di ricarica è conforme ai vigenti standard tecnici e di sicurezza;
- l’installazione del punto di ricarica è effettuata da un soggetto abilitato e nel rispetto delle norme di sicurezza elettriche;
- l’installatore deve rilasciare un certificato di conformità dell’impianto e del suo funzionamento alle norme di sicurezza elettrica.
Qualora l’infrastruttura di ricarica per veicoli alimentati ad energia elettrica ricada in aree sottoposte a vincoli, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta dalla normativa nazionale, regionale e/o locale speciale vigente (es.: autorizzazione paesaggistica – ambientale, ordinaria o semplificata, ecc.).
ATTIVITÀ SOGGETTA A SEGNALAZIONE
In tutti i casi non ricadenti nei punti sopra citati, è necessario presentare una SCIA (Segnalazione Certificata di Inizio di Attività) e una documentazione a corredo così come stabilito dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con il Decreto 3 agosto 2017.
Documentazione da presentare a corredo della SCIA
Allegato 1 (Decreto 3 agosto 2017 – SCIA punti di ricarica veicoli elettrici)
Documenti e elaborati tecnici da presentare a corredo della segnalazione certificata di inizio attività ai sensi dell'art. 23, commi 2-bis e 2-ter, del decreto-legge 9 febbraio 2012 n. 5, convertito in legge 4 aprile 2012 n. 35
Alla segnalazione certificata di inizio attività devono essere allegati i seguenti documenti:
- documento di inquadramento del progetto. Il documento di inquadramento del progetto contiene:
- la descrizione del progetto: progetto comunitario, progetto nazionale, investimento privato, ecc.
- il numero delle infrastrutture di ricarica previste dal progetto
- le motivazioni sottese alla scelta delle localizzazioni proposte
- l’indicazione dei costi complessivi suddivisi per la parte di investimento e per le parti di gestione e manutenzione successive
- l’indicazione del soggetto che provvederà della gestione e manutenzione delle infrastrutture di ricarica
- le modalità e le attività di informazione e comunicazione previste
- progetto tecnico. Per ogni infrastruttura di ricarica deve essere presentato un progetto tecnico, comprensivo di:
- inquadramento territoriale ed estratti dei principali strumenti urbanistici vigenti
- documentazione fotografica ante operam
- particolari costruttivi/installativi
- ante e post operam
- segnaletica orizzontale e verticale
- cronoprogramma inclusivo di indicazione dei tempi di fine lavori, operatività dell’infrastruttura di ricarica sia in termini tecnici (funzionalità) che di regolamentazione dell’area che ospita l’infrastruttura e lo/gli stalli di sosta riservati alla ricarica così come previsto dall’art. 17, comma 1 del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016
- relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica. La relazione sulle caratteristiche tecniche dell’infrastruttura di ricarica deve contenere almeno le dimensioni, i colori, l’interfaccia con l’utente, gli standard delle prese di cui allegato del decreto legislativo n. 257 del 16 dicembre 2016, le modalità di accesso e pagamento, eventuale upgradabilità del software del sistema di gestione, smaltimento delle apparecchiature a fine vita. I punti di ricarica realizzati in aree pubbliche o private aperte ad uso pubblico devono assicurare l’interoperabilità tra i sistemi di ricarica
- copia della richiesta di connessione alla rete di distribuzione elettrica o di modifica della connessione esistente, ai sensi della regolazione dell’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (in particolare, allegato A alla deliberazione 646/2015/R/eel e allegato C alla deliberazione 654/2015/R/eel)
ACCATASTAMENTO
Oltre a ciò, in relazione all’infrastruttura di ricarica bisogna tener conto che l’area dove sostano gli autoveicoli è di fatto e di diritto un parcheggio e in quanto tale deve sottostare alle norme che regolano l’obbligo di censire nell’archivio pubblico denominato Nuovo Catasto Edilizio Urbano. Per cui andrà fatto un aggiornamento del catasto o nuovo accatastamento ricordando che un’infrastruttura di ricarica, nelle sue diverse parti essenziali – stalli, caricatori, cabina elettrica e trasformatori – non può essere composto da unità immobiliari che hanno una rendita catastale pari a zero.
REGISTRAZIONE AL SINFI
Quando la “colonnina di ricarica” è al servizio del pubblico, deve essere raggiungibile anche digitalmente. È un oggetto dotato di elettricità e di connettività di rete ed è in grado di diventare un punto di connessione della rete 5G. Ciò comporta l’osservanza di un obbligo relativo alla registrazione di questa infrastruttura in un pubblico registro denominato SINFI, Sistema Informativo Nazionale Federato delle Infrastrutture, anche detto Catasto delle Infrastrutture. Chi si occupa della progettazione dell’infrastruttura di ricarica e della sua realizzazione dovrà tener conto della relativa norma (Decreto 11 maggio 2016 del Ministero dello Sviluppo Economico).
AUTORIZZAZIONE AI VIGILI DEL FUOCO
Esistono anche autorizzazioni da chiedere al comando dei VV.F (Vigili del fuoco)? Secondo uno studio di tecnici dei VV.F., ricercatori, rappresentanti del CEI e produttori di auto, i veicoli elettrici non presentano un livello di rischio di incendio maggiore rispetto ai veicoli tradizionali. Pertanto, con l’obiettivo di favorire la mobilità elettrica e sostenibile, il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile ha emanato le “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici”. In questo regolamento viene espressamento detto che le colonnine di ricarica non rientrano fra le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. n. 151 del 1 agosto 2011).
Invece, se l’infrastruttura di ricarica viene installata in un’attività soggetta a controllo dei VV.F., si presentano due casi:
- vengono rispettate le indicazioni riportate nelle “Linee guida” e di conseguenza si può considerare l’installazione dell’infrastruttura di ricarica non rilevante ai fini della sicurezza antincendio, mantenendo comunque l’obbligo di presentare e conservare la documentazione relativa;
- l’installazione non è realizzata secondo quanto previsto dal documento dei VV.F. e sarà quindi da considerare come una modifica rilevante ai fini della sicurezza antincendio con tutte le implicazioni di valutazione del rischio che comporta.
__________________________________________________________________
Il Consiglio Nazionale Periti Industriali, CNPI, ha realizzato un’utile guida per quanto riguarda la realizzazione di colonnine di ricarica, dal titolo: “Infrastruttura di ricarica di veicoli elettrici”. Nel documento vengono forniti i requisiti, gli adempimenti normativi che devono rispettare e quali incentivi sfruttare.
Si tratta, quindi, di un valido strumento a disposizione dei professionisti chiamati a progettare, realizzare e manutenere un’infrastruttura di ricarica elettrica per auto, bici e moto.
Il documento esamina le misure tecniche, amministrative ed economiche per il controllo e l’organizzazione dell’habitat urbano correlato alla funzione di ricarica di auto, bici e moto elettriche.
__________________________________________________________________
DETRAZIONI
CIRCOLARE N. 19/E
Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli alimentati ad energia elettrica. (Rigo E56 – Sez. III C) Articolo 16-ter decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 Articolo 9, decreto Ministero dello Sviluppo Economico 20 marzo 2019.
La detrazione spetta a tutte le spese legate alla messa in opera dei punti di ricarica per autovetture elettriche, a condizione che vengano sostenute tra il 1 marzo 2019 e il 31 dicembre 2021.
In queste spese sono incluse:
- i costi d’acquisto dell’infrastruttura;
- i costi della messa in posa;
- le spese per l’aumento della potenza del gruppo di misura;
- le spese legate alla procedura di allaccio.
La detrazione prevista dall’imposta lorda è pari al 50% delle spese sostenute. I beneficiari della detrazione possono essere sia i soggetti IRPEF che i soggetti IRES, i quali, però, devono sostenere effettivamente la spesa e detenere l’immobile o l’area nella quale è posta l’infrastruttura in base ad un titolo idoneo quale proprietà, usufrutto ecc.
__________________________________________________________________
Link Utili:
Di seguito i link per scaricare le applicazioni dei principali servizi di ricarica nei due store di riferimento:
Enel X
BeCharge
Duferco Energia
Ionity
Neogy
EvWay by Route 220
APP per trovare le colonnine
Partner